Senza categoria / Walter Veltroni
“La condanna” di Walter Veltroni | Una storia che lega passato e presente
Scritto da:
Redazione BookToBook
03 Apr 2024
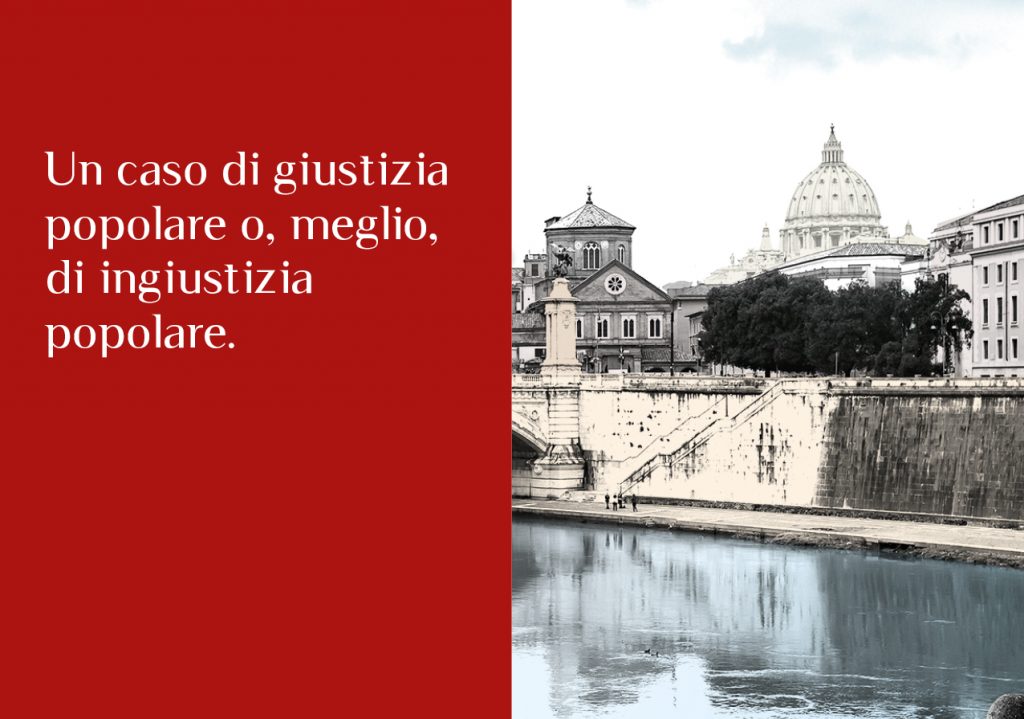
Giovanni ha ventiquattro anni e lavora nella redazione di un giornale, fa i turni di notte, per la chiusura del giornale e l’aggiornamento del sito. Non è cresciuto «nel velluto», per lui nulla è stato facile. «Mio padre faceva il maestro elementare, non il manager o il creativo digitale, e quando un giorno se ne è andato come non avrebbe voluto, un infarto proprio davanti ai suoi alunni, io ho capito che toccava a me. Avevo quattordici anni, figlio unico, mia madre segretaria in uno studio medico. Non potevo far altro che quello che ho fatto: studiare. E avere un sogno, quello che condividevo con papà. Lui mi ha insegnato che i giornali erano la messa laica, che leggerli, metabolizzarli, era l’unico modo di essere cittadini consapevoli. Per sua fortuna non ha fatto in tempo a vedere l’imbarbarimento dell’informazione, drogata dai social, e la crisi dei suoi amati quotidiani, quelli che leggevamo insieme la sera, prima di cena».
Una sera, prima di uscire dalla redazione, il caposervizio della cultura Sergio Fabiani chiama Giovanni nel suo ufficio. È un uomo colto, sui sessantacinque anni; ha la scrivania piena di libri, «credo che la sua consuetudine con i romanzi sia superiore a quella con gli esseri umani», pensa Giovanni. Qualche giorno prima Sergio gli aveva chiesto di trovargli della documentazione sul caso Carretta. Giovanni non ne sapeva nulla.
La condanna è una storia che lega passato e presente
Ed è così che, con la precisione dello storico e lo sguardo da scrittore, con la sollecitudine della memoria e la sensibilità del narratore, Walter Veltroni – già direttore dell’“Unità”, vicepresidente del Consiglio, sindaco di Roma, fondatore e primo segretario del Partito democratico, saggista e regista – ci riporta a Roma nel settembre 1944, a un passato da ricordare e da sviscerare ancora, perché tra le righe della storia del Novecento d’Italia s’annidano fatti, cronache, vicende poco indagate, forse dimenticate, che però meritano attenzione oggi più che mai.
Dopo La scelta, Walter Veltroni torna ai temi suoi più cari e con La condanna, da poco in libreria per Rizzoli, richiama ancora una volta la nostra attenzione, la nostra partecipazione a una storia che lega passato e presente, che fonde la narrazione con la realtà, che ha come protagonista principale, nobile, autorevole la ricerca della verità, spirito guida di ogni tempo e di ogni epoca, linfa e nervatura di ogni romanzo davvero storico e, per ciò stesso, imprescindibile per quanti non soltanto non vogliono dimenticare, ma non rinunciano a riflettere sulle lezioni della storia condivisa di un popolo.
Con La condanna Walter Veltroni sceglie di raccontare una storia scomoda, una storia che ha dell’incredibile nella sua crudezza cronachistica, nella sua verità sconvolgente, nell’efferatezza, nella violenza, nella follia di cui si rese colpevole il popolo italiano. Veltroni sceglie questa storia non a caso, lo capirà fin da subito chi legge, tante e svariate sono le connessioni col nostro presente. Non a caso, l’autore sceglie come protagonista un giovane giornalista (mestiere che oggi sta purtroppo perdendo di fascino e di incisività agli occhi della gente), cui affida non soltanto la dimensione universale della speranza a correzione degli errori compiuti, ma pure la fiducia nella capacità individuale, personale, civica di ripristinare la prospettiva su ciò che conta sul serio per il bene comune, di “studiare”, come fa Giovanni, al fine di costruire un futuro più sensato, più giusto per tutti.
La storia, vera, attorno cui Walter Veltroni costruisce il suo romanzo storico ha molto a che fare con il senso di giustizia nel più ampio dei suoi significati possibili. E difatti questa storia non può lasciare indifferenti, non può non indurci a riflettere sulle storture della contemporaneità, sui rischi e sui pericoli cui sono soggetti non soltanto i principi democratici della libertà, del diritto a tutela dei singoli cittadini di fronte alla legge, ma le nostre singole vite nello svolgersi quotidiano dei nostri ruoli, dei nostri compiti, del nostro libero esercizio d’esistere.
Visualizza questo post su Instagram
La condanna racconta il linciaggio di Donato Carretta
La vicenda, che appartiene alla storia d’Italia, è quella di Donato Carretta, direttore del carcere di Regina Coeli negli anni del fascismo in Italia e della Seconda guerra mondiale, chiamato a testimoniare contro Pietro Caruso, questore di Roma durante la dominazione nazista. Donato Carretta finirà ammazzato da una folla inferocita, linciato dall’odio cieco e vendicativo, dall’ignoranza pregiudiziale, il suo corpo appeso a testa in giù alle finestre di Regina Coeli da un processo di popolo sommario fomentato da pulsioni irrazionali e brutali. A staccare il corpo dalle finestre del carcere sarà il medico di Regina Coeli, appena tornato dalla clandestinità dopo aver partecipato all’evasione, dallo stesso carcere, di Sandro Pertini e Giuseppe Saragat, nel gennaio di quell’anno. «Lui, Fernando Monaco, medico socialista, Carretta lo conosceva bene. Perché quell’uomo appeso per i piedi l’aveva facilitata, l’evasione dei capi dell’antifascismo».
Da qui, ben si capirà leggendo La condanna, il rimando ai processi mediatici accusatori, denigratori, verbalmente brutali veicolati dai social si fa tanto evocativo quanto inquietante. «Un caso di giustizia popolare o, meglio, di ingiustizia popolare».
Ma torniamo alla storia. Roma è stata liberata da tre mesi, Hitler è ancora al potere, «Mussolini si è rifugiato al Nord, protetto dai nazisti, e celebra stancamente quel rito macabro che sarà la Repubblica sociale». Un mese prima, l’11 agosto 1944, il nuovo questore di Roma, Morazzini, aveva inviato all’Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo, Mario Berlinguer, padre di Enrico, una denuncia a carico di Caruso, accusato di aver aiutato i nazisti a compilare la lista dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Due mesi prima, a luglio, sono state esumate le vittime. «Verranno trovati trecentotrentacinque corpi, ammassati in colonne che raggiungono il metro e mezzo di altezza. Trentanove sono decapitati e si capisce subito che quei poveri cristi non sono stati uccisi, come si pensava, con raffiche di mitra. Ma uno a uno, con un colpo di pistola alla testa».
La mattina del 18 settembre, quando dovrebbe tenersi il processo a Caruso al palazzo di Giustizia di Roma, «la città si risveglia con le notizie contrastanti sugli sviluppi della guerra», ci ricorda Veltroni. «Secondo i giornali del Nord, editi sotto il ferreo controllo della Repubblica sociale e dei comandi nazisti, Hitler sta scatenando ‘vigorosi contrattacchi tedeschi su tutto il fronte occidentale’ mentre il “Corriere di Roma”, che nei giorni successivi alla liberazione sostituisce “Il Messaggero” per segnare una discontinuità con il passato regime, titola: Gli alleati si avvicinano a Colonia».
Sono centinaia i romani che in quel giorno di settembre raggiungono “il Palazzaccio” per assistere al primo processo ai fascisti nell’Italia libera. «Gli italiani sono divisi, sospesi. Le ferite della dittatura, dei bombardamenti, della fame, della guerra civile sono ancora tutte aperte», scrive Veltroni. «L’odio per certi protagonisti di quel regime, i gerarchi furfanti arricchiti, le spie e i torturatori, dominava quei giorni». Ogni romano aveva pagato un prezzo, ci ricorda Veltroni. «Ogni comunità contava qualcuno caduto al fronte, durante i bombardamenti, alle Fosse Ardeatine, nelle carceri naziste di via Tasso o in quelle gestite dalla banda Koch, di via Romagna 30 e di via Principe Amedeo 2. In molte di queste situazioni di mezzo c’era sempre Pietro Caruso». Eppure, nessuno dei cittadini che il 18 settembre affollano il tribunale «ha mai visto in volto l’oggetto del proprio odio», il questore Caruso. «Mai una sua foto è stata pubblicata, su nessun giornale». Basterà un dito puntato contro Carretta per azionare il meccanismo della giustizia sommaria. Basterà che una donna, Antonietta Pitotti, moglie di Alberto Marchesi, militante comunista ucciso alle Ardeatine, scambi Carretta per Caruso, basterà il suo giudizio errato, infondato, non confermato da prove, a decidere della vita e della morte di Donato Carretta.
Le pagine in cui Walter Veltroni descrive il linciaggio sono impressionanti. Fanno venire i brividi la furia e il delirio con cui la massa si scaglierà contro Carretta, fino all’esito fatale non riportato dalla cronaca su pellicola che del processo fece Luchino Visconti quel giorno con la sua troupe e le sue macchine da presa.
«Il girato sarebbe stato selezionato da Mario Serandrei, uno dei più grandi montatori italiani, che con Marcello Pagliero, Giuseppe De Santis e lo stesso Visconti avrebbe poi firmato la regia di questo film, Giorni di gloria, che racconta con immagini fortissime, come quelle della riesumazione dei corpi delle vittime delle Ardeatine, la storia italiana tra il 1943 e il 1945, specie quella del movimento partigiano e antifascista».
E qui la voce di Veltroni regista si fa critica e acuta, nel porre un interrogativo per bocca di Loredana, l’altra giovane speranza di queste pagine sentite, l’amica giurista di Giovanni che lo aiuterà, con passione, con dedizione, con crescente convinzione nel ricercare la verità della storia, a ricostruire i fatti e a scrivere una degna pagina di giornalismo. Perché non hanno girato la scena del linciaggio? «O invece l’hanno girata e poi l’hanno tagliata? E se l’hanno censurata, perché?», si chiede Loredana che, insieme a Giovanni, va a rileggere incredula la spiegazione data ai tempi da Giuseppe De Santis, regista del neorealismo. «Per quanto riguarda il linciaggio di Carretta, qualcuno degli operatori si trovò fuori e Luchino naturalmente gli disse di seguirlo e girò anche il linciaggio. Non l’abbiamo mai montato tutto, nel film ce n’è soltanto un pezzettino. Non lo montammo per amore patrio, ci sembrava che far vedere in quel momento un furore così terribile, drammatico, tragico del popolo romano contro l’ex direttore di Regina Coeli fosse eccessivo. Forse sbagliammo, ma la nostra era una posizione politica e poetica. Si trattava di un episodio isolato, il popolo italiano era ben altro».
È un romanzo intenso, La condanna, per i crudi fatti veri che narra e per le domande di civiltà che pone, per la potenza dell’insegnamento della storia e per i riflessi in controluce che essa allunga sul nostro presente, per chi crede ancora nel giornalismo e nell’informazione come strumento irrinunciabile di democrazia e di libertà, per quanti confidano nella partecipazione e nell’iniziativa dei singoli. Come il tenente dei carabinieri Giambattista Vescovo, che il 18 settembre del 1944 tentò di salvare la vita a Donato Carretta, così come tentò di fare il tramviere Angelo Salvatori fermando la corsa e rifiutandosi di seguire la massa che, con Carretta inerme steso sui binari, gli urlavano di «farne salsicce».
Salvatori è l’unico essere umano, fa dire Veltroni al suo giovane protagonista Giovanni, «ad avere il coraggio, come i professori che si opposero al fascismo, di dire di no al pensiero unico che circola in quella piazza infoiata». Quell’uomo, in un istante, ci dice Walter Veltroni, «ha deciso di fare due cose precise: ha mostrato la tessera del PCI per far capire che si poteva essere comunisti senza partecipare a uno scempio simile, e che lui si rifiutava di finire quell’uomo non solo perché lo riteneva disumano, ma anche perché era sbagliato». Il tramviere non conosce storia e identità dell’uomo che giace sui binari del suo tram. «Forse è un fascista, come la gente gli grida per incitarlo a punirlo. Ma ad Angelo Salvatori questo non basta. In quel momento, finita a Roma la guerra civile, la giustizia la faranno i tribunali, non le folle urlanti. Il tramviere non ha studiato giurisprudenza, ma sa che la libertà ha delle regole, diversamente dalle dittature. Sa che la vita umana, in democrazia, non è più alla mercé della violenza o delle ideologie, anche quelle più vicine. Sa, con la saggezza del popolo e la sua umanità. Sa che il popolo non è la folla, che la giustizia non è la vendetta, che la rabbia fa strame del diritto». Quando sfila la manovella, Angelo Salvatori «rende il suo tram un corpo inerte e prolunga la vita di quell’uomo con la camicia piena di sangue. Una tessera e una manovella. Sono i simboli dell’umanità che si difende, in quel giorno di sole esagerato, mentre grandina odio».


